#47 - PRIGIONÌA
Ore 6.01
Francesca si alza per prepararsi al turno di Automedica.
Passa davanti alla cucina assonnata e mi trova intento a scrivere in cucina, accanto al frigo rosa, totem della nostra casa, acquistato prima della nascita delle nostre tre Minions e rivelatosi di un colore profetico. Le pupe ed io ci abbiamo appeso, con la colla patafix, un disegno di Federica che ritrae la mamma vestita da dottoressa, con un mantello da supereroe.
Mi saluta con sguardo dolce e sbigottito (sopra la sua testa un fumetto: ma perché non dorme un po’ di più lui che può?! ).
Va a prepararsi e io mi godo il silenzio della giungla, il momento più tranquillo della giornata. Minions pacifici, ogni tanto vado a spiarne le posizioni divertenti. Bianca fa ancora quella supina con le braccia buttate all’indietro, sopra la testa, e le gambe divaricate. Stella marina del mio cuore.
Ore 7.00
Io e Francy beviamo un caffè insieme, lei legge il mio post giornaliero in anteprima. Se ho già impaginato vede anche le foto e i link che aggiungo. Preferisco che sia così, ma non sempre faccio in tempo.
Ore 7.15
Mamma Francy parte per andare al lavoro e - nonostante dopo quasi 2 mesi l’idea che vada a vestirsi da astronauta con la tuta anti-contagio io l’abbia quasi metabolizzata - la osservo dalla finestra.
Mi viene voglia di dirle qualcosa, qualsiasi cosa, giusto perché non si strappi il filo invisibile che tiene il mio sguardo incollato al suo passo svelto e ai suoi capelli che ondeggiano ricordandomi il suo profumo.
- Prendi la mia auto oggi? Sta troppo ferma, se non la muoviamo addio batteria.
- Ok Paul. Ciao bellino.
Sintetica. Ma almeno ho catturato un suo sorriso in più, mentre si girava a veloce a rispondermi.
Ed eccomi qui. Mentre la gang continua a russare porto cane Juliano a fare il suo giretto, ormai mi fido a lasciare la quasi tredicenne come commander in chief per qualche minuto e poi fino alle 9 qui non si sveglia nessuno, l’anda è ormai quella.
Girando in tondo come se il quartiere fosse il cortile di un carcere, spiego imbarazzato per l’ennesima volta al quadrupede biondo che dobbiamo rimanere entro i 250 metri di raggio da casa. Mi guarda con occhi languidi e giudici. Mai severo, mi fa comunque sentire un aguzzino. E da quando indosso la mascherina pare mi scruti dubbioso sul senso di quella museruola per umani.
A tratti mi sembra di vivere questo loop da sempre. Altre volte ho ancora la sensazione che sia una parentesi. In lontananza ne scorgo la fine, spinto dal vociare di tutti i dibattiti sulle riaperture in corso e dalle domande pressanti sulle nuove regole da definire per la vita dopo il lockdown.
Questo navigare a vista mi spaventa un po’, di certo perché speravo che questo periodo fosse una vera parentesi e mi illudevo di uscire dal labirinto dimenticando il Minotauro Covid-19. Invece ho capito che dovremo abituarci a portarlo a guinzaglio, nella vita di tutti i giorni, per un po’.
Devo riconfigurare la mia forma mentis, forgiatasi nel secolo scorso.
“ La verità è che c’era una volta il futuro. Non faceva paura e non aveva bisogno di astrologi per essere divinato. Si chiamava Duemila, numero così perfetto che non si esauriva che non si esauriva nel concetto di un anno, ma era il sogno di un’epoca. Un vocabolo così eccitante che tutti se impadronivano per battezzare le loro iniziative. Progetto duemila, alfa duemila, bar duemila, vacanze duemila, lavasecco duemila.
Il progresso era un “dono del Signore”, non esistevano mostri come Aids, Osama Bin Laden, Fumo che uccide, Pacchi bomba, Stragi del sabato sera, Crack Parmalat. Fra le date da ricordare non c’erano il 2 agosto, l’11 settembre 2001, l’11 marzo di Madrid. E la borsa era quella della spesa: per sfidare la fortuna c’era il Lotto ”.
Sono cresciuto con questa idea di futuro, descritta perfettamente dalle parole di Luca Goldoni nel suo libro Appena Ieri - Come non siamo cambiati (2005).
Lo riprendo in mano preparando una lezione per il mio corso d'Accademia dedicato ai Consumi Culturali. Pur mantenendo invariato il programma di base, mi sembra giusto inserire nuovi spunti di riflessione legati alla situazione che stiamo vivendo a causa del Coronavirus.
Uno dei miei pensieri fissi in questo periodo è la domanda: quale percezione del mondo e del futuro avranno i nostri bambini, adesso? Voglio dire, l’attivismo di Greta Thunberg ci insegna che fin da piccoli ci si può fare un’idea chiara dei problemi del Pianeta. I nostri ragazzini, ora, oltre che con l’inquinamento e il global warming, devono fare i conti con la pandemia. In questi giorni in modo diretto, restando a casa. E poi? Domani cosa accadrà? Quali preoccupazioni avranno? Per i loro nonni, ad esempio, che sono più a rischio contagio. Senza contare i traumi da superare, nelle famiglie che hanno subìto perdite.
Ci vorrebbe un mito da inseguire, un faro verso il quale puntare, come il Duemila.
Quando io, da bambino, pensavo all’avvicinarsi lento e inesorabile dell’anno 2000 provavo un piccolo brivido d’emozione, immaginandomi ormai grande, indipendente. Il futuro mi incuriosiva e non faceva paura, poteva al massimo togliere il fiato come un tuffo fatto per la prima volta da un trampolino più alto del solito.
Mi consola, ragionando sulle righe scritte da Goldoni, ricordarmi che tutto sommato anche il mondo degli anni Ottanta e Novanta non era un completo idillio. Semplicemente era patinato dall’entusiasmo per il consumo, spinto a rotta di collo dalle tv commerciali, che ci illudevano di essere messaggere di un nuovo benessere democratico, alla portata di tutti. L’ennesima declinazione del sogno americano, come un secondo Miracolo Economico fuori tempo massimo.
In fondo sono stati famiglia, scuola ed artisti a svelarmi i dettagli del tempo nel quale stavo davvero crescendo. In tv tutto assumeva la forma di un grande party, da Drive In a Non è la Rai, fino al pruriginoso Colpo Grosso (ora riproposto in replica, come medicina per la noia del lockdown) condotto da Umberto Smaila, con quel cognome che ricordava la parola inglese sorriso. Sornione.
E invece erano tutte chimere: “Sorridi, sei su Candid Camera” ci sussurrava la vocina della coscienza, mente Jerry Scotti iniziava la sua ascesa al successo conducendo una trasmissione di nome… Smile!
Tutto era “confezione”, addirittura i settimanali di approfondimento, come L’Espresso e Panorama, andavano riconosciuti tali superando le audaci quanto assurde promesse in copertina, dove svettavano procaci ragazze in topless, senza alcun motivo se non essere un esplicito amo per il marketing. Senza imbarazzi, non tanto per la nudità, quanto per l’esplicita funzione di donna-oggetto palesata. Vivevo un cortocircuito culturale: crescevo in un landa bigotta ad intermittenza, che si raccontava come un Paese dei Balocchi, mentre veniva attraversato tuttavia da stagi di mafia, crisi di governo, politici spesso in rissa o in fuga.
Anche a distanza di decenni è orribile, questa presa di coscienza: tuttavia oggi quasi rassicurante.
Eh sì, perché mi ricorda quali furono i miei appigli nella tempesta: ad esempio i racconti di guerra di mio nonno materno, ufficiale dell’aeronautica, soprattutto quelli della prigionia in Algeria. Vorrei avere un suo diario per rileggerli, oggi. Invece mi restano solo aneddoti e sensazioni. Ricordo perfettamente il mio stupore, ogni volta, immaginandolo bloccato in un campo dell’Africa Settentrionale per tre anni, dal maggio 1943 al maggio ‘46: ebbene sì, un anno dopo la fine della guerra, perché rimpatriavano prima i più anziani. Lui, benché ufficiale, era giovane, nato nel ‘21. Altro che quarantena.
Come passavate le giornate? Dove dormivate? Cosa mangiavate?
Da bambino, ciclicamente, gli ripetevo queste domande. Soprattutto quando chiacchieravamo sul balcone della sua casa di montagna, dove trascorrevo lunghe settimane estive, mentre insieme guardavamo le pinete alle pendici dell’Adamello. Lui seduto sulla sua poltrona preferita, una sorta si sedia-sdraio rivestita di finta pelle color tabacco. Io in piedi, con il suo grande binocolo tra le mani, puntato verso le cime. Rispondeva a tutte le mie curiosità. E poi mi confidava sempre di sognare un bel piatto di spaghetti ai con i ricci di mare.
Studiava, in prigionìa, sui libri procurati dai religiosi protestanti francesi.
Al rientro si è laureato in Giurisprudenza, nel dicembre 1948, sostenendo anche un esame universitario con Aldo Moro come docente. Dormiva in terra. Mangiava poco: la felicità era rappresentata da un qualche dattero, di tanto in tanto, barattato con i beduini di passaggio: scendevano dal cammello e offrivano ai prigionieri questi frutti che trasportavano appesi alla cintura. Non c’era da esser schizzinosi. E che risate quando nonno me lo raccontava, il suo grande insegnamento è stato confidarmi tutto ciò con il sorriso e poche pennellate di malinconia. L’amore per la nonna, bellissima, che non si stancava di aspettare in Valtrompia proprio lui, un pugliese conosciuto prima della guerra. La sua infanzia a Bisceglie, orfano di mamma fin dai 3 anni. Il liceo a Trani, con quella cattedrale sul mare che “vedevo” nelle sue descrizioni, e una famiglia con tanti fratelli e sorelle, prima molto uniti, e poi divisi nello spazio, ma non nei sentimenti, dalle scelte di vita di ognuno. Centinaia di chilometri per vedersi, di solito per matrimoni e funerali. Una vita di parole confidate nella cornetta del telefono, nell’appuntamento settimanale in chiamata interurbana che univa Puglia e Lombardia. Sentivo anch’io, passandogli accanto, la voce squillante e gioiosa della sua amata sorella, zia Nennella. La adoravo, fin da bambino, e la incoronai regina dell’ospitalità quando, oltre alle mille attenzioni, a quindici anni mi offrì una birretta. “Ma è piccolo…” - sorrise mia madre. “Beh, è nell’anno dei sedici! Poi li compirà ed entrerà nell’anno dei diciassette. È così che si conta l’età” - rispose risoluta la super-zia. Quante risate insieme. Mi sentii davvero più grande, da quel giorno.
Ecco, tenacia e voglia di ridere. Al di là del contesto, questi sono gli assi cartesiani del mondo che vorrei che le mie figlie imparassero a conoscere. Ciarliero e pandemico così com’è oggi, perché per cambiarlo abbiamo bisogno di prenderne coscienza, prima.
In fondo anche Forrest Gump, personaggio emblema di una normalità a tratti disarmante, del film di Robert Zemeckis, attraversa vicissitudini storiche di ogni tipo (compresa la guerra in Vietnam) con tratti eroici senza voler essere chiamato eroe, come sta facendo tutto il personale sanitario, oggi, compresa Francesca, Rianimatrice e madre, e mi piace pensare che, chissà, forse i motivi per cui mi sono innamorato di lei ormai vent’anni fa, risiedano anche nelle sue origini radicate nell’Alta Valtrompia. È pragmatica. Decisa. La connessione Lombardia-Puglia è solida.
Alle nostre figlie non serve aspettare il Duemila, hanno lei come orizzonte di riferimento. Hanno l’esempio memorabile del suo impegno e di quello dei tanti che come lei stanno contrastando l’attacco globale del Covid-19. Un’abnegazione fatta di gesti quotidiani che esprimono senso di responsabilità. Anche nei piccoli gesti, come quando nel suo giorno di riposo, sta seduta accanto a noi nel co-working casalingo, a seguire webinair della SIAARTI per essere aggiornata su tutti gli sviluppi delle cure, nei diversi ospedali d’Italia e del mondo.
In una scena di Forrest Gump, il protagonista inventa il simbolo dello smile, trasformando schizzi di fango in un sorriso. Nella sua semplicità, si tratta di una lezione di vita (e di sceneggiatura) preziosa.
Parole affascinanti, come Duemila, ed eroismo servono a catturare l’attenzione. Ma sono le esperienze quotidiane a seminare senso. Emozioni che potranno germogliare, in futuro.
__________



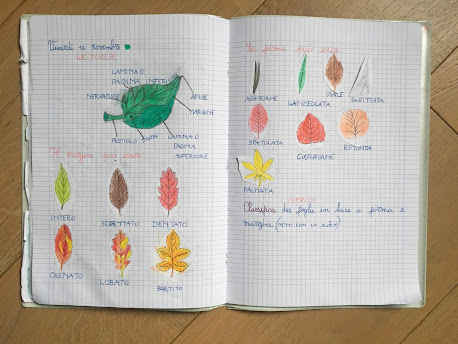
Commenti